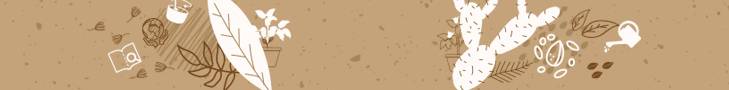Il primo edificio penitenziario costruito sul territorio italiano con un sistema innovativo fu l’Ergastolo sull’isolotto di Santo Stefano, nell’arcipelago delle Isole Ponziane, a poca distanza dall’isola di Ventotene. Si narra che fu Ferdinando IV re di Napoli e della Sicilia (1759-1816) a volerne la costruzione. Salvatore Schiano di Colella, studioso e guida turistica del penitenziario, spiega: « L‘architetto Francesco Carpi, che realizzò il carcere tra il 1791 e il 1797, aveva in mente il Teatro San Carlo di Napoli. La forma a ferro di cavallo e le proporzioni sono esattamente quelle. Solo che qui i detenuti mettevano in atto la loro tragedia nei palchi, mentre al centro, sul palcoscenico, c’erano le guardie. Grazie alla sua circolarità l’edificio ottimizzava l’utilizzo dei secondini, ne bastavano 100 per quasi mille carcerati».

Questo criterio fu poi teorizzato da Jeremy Bentham (1748-1832) nel suo progetto denominato Panopticon. Su questa base si costruirono i penitenziari nel XIX secolo. Negli Stati Uniti si diffuse maggiormente rispetto all’Europa. Nel 1831-32 Alexis de Tocqueville si recò in Pensylvania, a Philadelphia, per studiarlo e proporlo in Francia. Così il sociologo ne esaltava il valore: «… novecento criminali, sorvegliati da solo trenta carcerieri lavorano liberi senza catene… E perché questi novecento malfattori, tutti insieme, mostrano di essere meno forti dei trenta individui che li sorvegliano? Semplicemente perché le guardie possono liberamente comunicare tra loro e agire simultaneamente e avere, quindi, tutto il potere dell’associazione mentre gli internati, separati l’uno dall’altro dal silenzio, hanno a dispetto della loro forza numerica tutta la debolezza della separazione».
La persona detenuta era obbligata a trascorrere tra quattro pareti spoglie ed estranee un tempo più o meno lungo. Qualsiasi fosse la sua detenzione sarebbe stata interminabile e lenta, in condizioni di vita disumane, in silenzio e senza avere alcun contatto con l’esterno. Per non lasciar morire la propria personalità in un luogo che tende ad annullarla, per mantenere la consapevolezza dell’ “esserci”, nacquero altri linguaggi comunicativi, i graffiti sui muri e sulla pelle e i tatuaggi.
Cesare Lombroso (1835-1909), padre della moderna criminologia ed esponente del positivismo, costruì una teoria perversa basata sul “carattere anatomico-legale” ereditario del criminale, che collega il delinquente “all’uomo primitivo o in istato di selvatichezza”. Lombroso studiò con attenzione i linguaggi carcerari, ignorati dagli altri studiosi del sistema penitenziario, come i graffiti e i tatuaggi.
«Il volgo ed anche il mondo scientifico credono in buona fede che il carcere, specie il cellulare, sia un organismo muto e paralitico o privo di lingua e di mani, perché la legge gli ha imposto di tacere e di restare immobile. Ma siccome nessun decreto, per quanto sostenuto dalla forza, può contro la natura delle cose, così quest’organismo parla, si muove e qualche volta ferisce e uccide a dispetto di tutti i decreti; solo che, come avviene sempre quando una necessità umana è in conflitto con la legge, esso si esplica per le vie meno note e sempre sotterranee e nascoste: sulle mura del carcere, sugli orci da bere, sui legni del letto, sui margini dei libri che loro si concedono nell’idea di moralizzarli, sulla carta che avvolge i medicamenti, perfino sulle mobili sabbie delle gallerie aperte al passeggio, perfino sui vestiti, in cui imprimono i loro pensieri di ricamo». (Cesare Lombroso, Palimsesti del carcere,Torino 1888. Dove il termine «palimsesto», nel suo significato etimologico, definisce una pergamena dalla quale è stata raschiata una prima scrittura per permetterne una successiva, i tatuaggi, fanno del carcerato una «pergamena vivente»).
Oggi i tatuaggi sono spesso associati all’estetica fine a se stessa, una moda che non sempre rispecchia un significato profondo. Nel passato i reclusi conferivano un’accezione simbolica e indelebile: era un modo per riappropriarsi del proprio corpo. Segni ed immagini per rivelare e affermare la propria identità annullata dal carcere ma anche un passatempo creativo ed uno scambio favori. Un tempo i tatuaggi erano un vero e proprio racconto personale, una storia disegnata sulla propria pelle per sottolineare l’appartenenza a un clan, a una regione, a un credo religioso. Una rappresentazione dei propri ideali ma anche un modo per invocare gli affetti, la famiglia e le relazioni amorose. Quei segni separavano l’apparenza della fraseologia comune dal senso dell’esperienza corporale consentendo di tralasciare il più per concentrarsi su ciò che importa: un modo per non farsi schiacciare dalla detenzione. Tatuaggio come forma di autolesionismo, per attutire il dolore più grande della prigionia, per fuggire i problemi familiari, personali, economici, irrisolvibili in quella condizione.
Gli strumenti con cui si praticava il tatuaggio erano pochi e semplici: la cannuccia di una penna a sfera e un ago per cucire. Si incideva la pelle tenendo l’ago in mano. Per fare il colore si utilizzavano le lamette da barba. Con l’accendino si bruciava la lametta sotto un pentolino. Il fumo che emanava la lametta rimaneva attaccato al fondo del pentolino, con un pezzo di carta si raschiava la cenere e si metteva in un piccolo recipiente per miscelarlo con una goccia di sapone liquido. Ne risultava una specie di china nero-blu con venature verde scuro.
Per scrivere sui muri era sufficiente un pezzo di matita, ma anche un mozzicone di sigaretta, il tacco di una scarpa, se di gomma, in casi estremi anche il proprio sangue. Il muro accetta tutto non giudica, non censura.
Pubblicato originalmente in BeLeaf 3, maggio 2017
Altri articoli di Salvatore Ricciardi